Con il lapis* #43: Maria Benedetta Cerro, Prove per atto unico. Prefazione di Tommaso Di Brango, Macabor Editore 2023
Viene d’assalto la mitezza
. a farsi elemento di passione.
L’ampiezza dell’aria
la finzione che al gioco piega la lingua dell’amore.
. Dove vai presente? Fermati ora.
La simil-vita si strugge per un’ora di ebbrezza.
Dille che non v’è dilazione
. che la sola certezza è l’invenzione
la cantilena sonora della lingua
che risana la vita lacerata.
(p. 63)
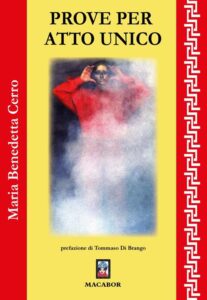 Collocati nella quarta sezione, Tentativi di riconoscimento, delle sei che compongono Prove per atto unico di Maria Benedetta Cerro, i versi sopra riportati esordiscono con un’immagine che reca con sé la natura e l’energia dell’ossimoro. La mitezza, dote preziosa e rara quanto poche altre, eco evangelica, che si carica di simboli e di suggestioni, si presenta come protagonista di un assalto.
Collocati nella quarta sezione, Tentativi di riconoscimento, delle sei che compongono Prove per atto unico di Maria Benedetta Cerro, i versi sopra riportati esordiscono con un’immagine che reca con sé la natura e l’energia dell’ossimoro. La mitezza, dote preziosa e rara quanto poche altre, eco evangelica, che si carica di simboli e di suggestioni, si presenta come protagonista di un assalto.
L’azione la precede – «Viene d’assalto la mitezza» – ed è questa a favorire il suo divenire, il suo «farsi elemento di passione». È così che la forza stessa di quella dimensione, di quella qualità che rovescia i rapporti di potere dominanti, la mitezza, riesce, nel suo dominio, a rivelare sia l’indissolubilità di amore e dolore nella passione, sia le contraddizioni e i conflitti che agitano la «simil-vita».
Nel tentativo di riconoscimento della vera vita, dell’autentico «atto unico» che spetta a ciascuno degli umani nella sua vicenda terrena, drammaturgia di una condizione che percorre stadi e stati differenti tra i poli della solitudine e della condivisione, il passaggio dal presente dell’indicativo al presente dell’imperativo caratterizza la parte centrale del componimento e si realizza per il tramite di due voci, entrambe da ricondurre all’io poetico in due diverse, e conviventi, dimensioni: la prima è l’invocazione, eterno ritorno della “umana troppo umana” Sehnsucht, dello struggimento che invoca all’attimo di fermarsi, la seconda è l’invito, rivolto all’interlocutore di una conversazione continua, colta qui per così dire “in medias res”, a spiegare alla simil-vita «che non v’è dilazione», che “il tempo prorogato” è revocabile.
Eppure, a fronteggiare la constatazione circa l’inesorabile precarietà, perfino di ogni illusione, interviene qui una pars construens, espressa con mitezza, ma con la salda convinzione della capacità di risanare della «cantilena sonora della lingua».
Si tratta di un passaggio importante, giacché viene delineata qui una via attraverso l’articolazione delle parole nella lingua della poesia e, come si intuisce, lo studio devoto per arrivare a tale efficace, e risanante, articolazione. Allo stesso tempo l’autrice illumina un aspetto della propria dizione poetica, la cui consapevolezza era già emersa al tempo della plaquette La soglia e l’incontro, allorché, a proposito della sezione Nella musica del verso, aveva scritto di «un ritorno (o un cedimento) a quella musica che ha sempre caratterizzato il mio pensare in versi e che spesso ho fieramente osteggiato come una insidiosa seduzione». In Prove per atto unico «la cantilena sonora» viene riconosciuta come una delle caratteristiche, una delle proprietà della lingua e a quella musica non ci si sottrae, come dimostrano non solo le allitterazioni e le rime in fine di verso, ma tutto il procedere del testo, che anche nella disposizione sulla pagina suggerisce l’inizio delle battute e le pause di una ideale partitura.
Per poter agire, risanando «la vita lacerata», la lingua deve sapere andare a fondo, tanto da trovare il punto dal quale è partita l’infezione, anche se per compiere questo atto occorre riattraversare tutto il dolore. È qui, in direzione contraria alla rimozione, che si incontra l’opposto della simil-vita (e l’inverso, l’opposto, sono una costante dell’opera di Maria Benedetta Cerro, come testimoniano sia passaggi ricorrenti, sia i titoli di alcune sue precedenti raccolte, come La congiura degli opposti, LietoColle 2012, e Lo sguardo inverso, LietoColle 2018:
Cos’è l’autentico
se non il ritrovamento del se stesso ignoto?
Comprendere che il tempo è mutamento
e chi eravamo non siamo.
Tentare un ritorno alla ferita
che si crede guarita
trovare il punto infetto
e senza esitazione andare a fondo. (p. 58)
Ancora a proposito della musica nella poesia di Maria Benedetta Cerro, nel breve saggio Per segni e sentieri inversi, apparso nel volume sesto di “Poeti del centro Italia” (a cura di Bonifacio Vincenzi, Macabor 2022), scrivevo, a proposito dei volumi già pubblicati, ma anche in riferimento a dieci testi inediti, in parte confluiti in Prove per atto unico (per la precisione, si tratta dei testi ora alle pagine 21, 22, 55, 64, 85): «Nella poesia di Maria Benedetta Cerro, nelle raccolte pubblicate così come negli inediti qui proposti, c’è la musica della vita e della parola che ha attraversato il fuoco come la salamandra e, insieme, la prova del ritmo, della misura esatta, che tale rimane anche quando, per accentuare l’animata dialettica di movimento e di pausa, l’endecasillabo viene diviso con tra due versi, con il secondo verso e, di conseguenza, la seconda parte dell’endecasillabo, che si sposta a destra rispetto al margine sinistro: «al tempo dell’infanzia/ erano ustioni» e «Tutto è ridotto/ a questo andare multiplo». C’è, ancora, in questa poesia, il canto del dolore e dello stupore, ci sono ascesa e meditazione, c’è, infine, l’esercizio spirituale quotidiano della registrazione, e della conseguente resa in versi, del prodigio: «Sentire profondissimamente/ ciò che è impossibile udire».
Movimenti in battere e in levare si alternano in una partitura dal respiro ampio: precipitare o calarsi nelle pieghe profonde del sé, là dove l’anima è marchiata «a ghiaccio e brace» e sollevare l’occhio, per esempio all’aia che si è fatta più deserta e alle violette fiorite nelle crepe».
In questo viaggio in sei tappe – Versi della mala pena, La mala hora, I luoghi dei labirinti, Tentativi di riconoscimento, La casa dell’armonia, I giuramenti del vento – che altro non è se non la «storia individuale» (Maria Benedetta Cerro nelle Note ai testi), l’attenzione alla lingua non è mai disgiunta da quella alla musica. Già, perché la poesia richiede, nell’atto unico della storia individuale e nell’atto creativo che è la sua natura, una propria lingua, una nuova grammatica. In Prove per atto unico, volume nel quale sono frequenti i testi al passato remoto, a indicare cesure sofferte, traumi trascorsi, ivi compresi quelli provocati dalla pandemia per COVID-19, lacerazioni avvenute, diventano fondanti la parola alla «grammatica dell’armonia», la scelta di «un tempo per il dire» e il dare nomi altri, nomi nuovi, tanto al «maggio dilaniato», quanto al risanamento.
Anna Maria Curci
*Con il lapis raccoglie annotazioni a margine su volumi di versi e invita alla lettura della raccolta a partire da un testo individuato come particolarmente significativo.